BIZANTINI E LONGOBARDI, QUANDO CHIUSI ERA UNA CAPITALE…

CHIUSI – Nella puntata di ieri la trasmissione “Passato e presente” in onda sui Rai 3 e su Rai Storia, condotta da Paolo Mieli, affrontava il tema delle invasioni barbariche, soffermandosi su cos’erano l’Italia e l’Europa nei secoli di passaggio tra la caduta dell’Impero Romano e il Medioevo. L’era dei Visigoti e Ostrogoti, dei Bizantini, di Odoacre, di Teodorico, di Galla Placidia, fino ai Franchi di Carlo Magno e ai Longobardi e ai sassoni e normanni… dalla saga di Re Artù a Federico II… Secoli lunghi, non brevi parentesi, dal 450 d.C. al 1200.
Regni e condottieri barbari sì, secondo la visione romana e romanocentrica, ma, alla fine, mica tanto… Roba che si studia alle medie e poi alle superiori, ma che sembra molto lontana da noi… Eppure anche quei secoli lì videro la penisola italiana e la “terra di mezzo”, quella che oggi sta a cavallo tra Toscana e Umbria ed ha il suo fulcro geografico sui due cucuzzoli dell’Amiata e del Cetona e corre dal Tirreno all’Adriatico attraverso la Maremma, la Valdichiana, il Trasimeno, l’Appennino e poi le Marche, come teatro di eventi rilevanti e alcune città ebbero un ruolo altrettanto rilevante.
Chiusi, per esempio, che con le invasioni barbariche riacquistò centralità grazie alla Cassia Vetus che vi passava. I Bizantini fecero ricostruire la Cattedrale, proprio in stile bizantino, più piccola nelle dimensioni, ma molto simile a Sant’Apollinare in Classe a Ravenna, capitale dell’Impero. Da qui anche la scelta successiva (più di mille anni dopo, alla fine dell’800) di decorarne l’interno con un “falso mosaico dipinto”, che richiama appunto i mosaici ravennati.
A partire dal 570, sotto la dominazione longobarda, per alcuni secoli Clusium toccò il massimo splendore. La città divenne sede di Ducato, uno dei primi nel suolo italico. Il ducato longobardo di Chiusi controllava i confini occidentali del cosiddetto Corridoio Bizantino e la Tuscia meridionale, essendo molto più esteso dell’antico ager chiusino; si pensi che esso comprendeva anche Siena, Cortona, Arezzo, Chiusi della Verna (Clusi Novi), l’Alto Lazio con Viterbo e Bolsena, l’intera area che oggi è la provincia di Grosseto e buona parte delle odierne province di Perugia e Terni, tra cui Orvieto, Castiglione chiusino, Paciano, Piegaro, S. Arcangelo, Agello, S. Venanzo, Mugnano, S. Biagio della Valle, Castrum Plebis e Montegabbione, tutto il Chiugi poi detto “perugino”…
La diocesi di Populonia (Piombino), all’epoca in grande decadenza, costituiva il cuscinetto tra il ducato chiusino e quello lucchese. Numerosi furono i tentativi dei duchi di Chiusi e di Spoleto di conquistare i vicini territori bizantini, tanto che nel 593 i Longobardi di Chiusi conquistarono un ulteriore lembo dell’odierna Umbria.
Chiusi aveva a quel tempo due “chiese madri”: la Basilica di Santa Mustiola, ristrutturata nel secolo VIII dal duca chiusino Gregorio, era probabilmente la chiesa madre (Longobarda) di rito ariano, mentre la cattedrale di San Secondiano era la chiesa madre (Cattolica) del Ducato chiusino. A Chiusi convivevano le due grandi “confessioni”.
Sul finire dell’VIII secolo, il Pontefice romano lamenta saccheggi e incursioni da parte dei longobardi di Chiusi a danno di Roma… Per la seconda volta dopo Porsenna, Chiusi prova a mettere le mani sulla città eterna…
Nell’814 l’imperatore Ludovico il Pio, nel tentativo di limitare lo strapotere delle famiglie longobarde dell’area chiusina, dona una parte del Trasimeno (già chiusino) al pontefice romano, rimanendo però detta donazione, per alcuni secoli, “lettera morta”. Da un documento di quel periodo si evince inoltre che Castiglione della Pescaia (GR) apparteneva, fino ad allora, al territorio sotto il dominio di Chiusi.
In sostanza, in epoca longobarda Chiusi è una vera e propria potenza.
Durante la dominazione Carolingia, nel IX Secolo, la città diventa un “Capoluogo” o Gastaldato, governato da un Gastaldo, direttamente dipendente dall’Imperatore. Il territorio ha confini più limitati rispetto al Ducato longobardo, ma comunque ampi. Alla fine del IX secolo le due grandi potenze dell’Italia centrale sono il Ducato di Spoleto e il Marchesato di Tuscia con sede a Lucca, la cui marca meridionale fa però capo a Chiusi.
Nel 746 per la sua posizione centrale e strategica Clusium diventa addirittura la capitale del Regnum Italiae, per via della minaccia dei Franchi che, richiamati dal Papa romano, avevano superato lo scoglio delle dighe alpine (create dai Longobardi per difesa militare), in particolare in Val di Susa, avendo così facile accesso al suolo italico: la storica capitale Pavia, a ridosso delle Alpi, era così un facile bersaglio per i Franchi, e parimenti Lucca si trovava subito dopo alcuni valichi appenninici, quindi per questo fu scelta Clusium, tra l’altro luogo ideale per tenere sotto controllo il corridoio bizantino, che univa l’Esarcato di Ravenna a Roma. Il vescovo di Chiusi importantissimo sotto il Ducato Longobardo, resta un “primate” rispetto a molti vescovi della terra di mezzo, anche con il Gastaldato. La città ha un’economia fiorente, medici, avvocati, notai tribunali…
E’ dalla metà del secolo X che per Chiusi iniziano i primi problemi. Problemi veri. La politica del ricostituito Sacro Impero Germanico, sotto la dinastia ottoniana, è quella di indebolire il Marchesato, di cui aveva paura, per ragioni politiche e specialmente militari, nonché per la paura di perdere la corona imperiale e per il controllo delle vie d’accesso a Roma, che attraversavano l’Etruria, specie la Via Cassia che transitava per Chiusi, la via dell’Alpe di Serra che vi passava molto vicino (Città della Pieve e colline castiglionesi) e una via all’epoca secondaria detta Francigena o Romea che da Viterbo saliva verso Siena passando a ridosso dell’Amiata.
In effetti, controllare Roma significava garantirsi la corona imperiale… E pertanto, l’impero germanico cominciò a mettere le comunità locali le une contro le altre. Le spaccature volute dagli Ottoni ebbero buon esito, e cominciarono così le guerre “di confine” tra Chiusi e Orvieto e tra Chiusi e Perugia (che nel frattempo si era affrancata dal Ducato di Spoleto e dal Marchesato di Toscana), guerre che furono difensive per Chiusi che era coadiuvata da una lega con Siena, Pisa e Arezzo e offensive per le altre due. Pertanto, a meno di venti chilometri a Sud di Chiusi, si creò un confine militare tra l’esercito della lega militare che sosteneva Clusium e la nascente città-stato di Orvieto. Non di rado le truppe orvietane o perugine (il cui confine era il Trasimeno) oltrepassavano i confini e conquistavano la sede di Contea, di Diocesi e di città giudiziaria di Chiusi, prendendone il controllo. Ma ormai siamo intorno all’anno 1000 e comincia un’altra storia…
Tra il 1052 e il 1055 il fatto che determina il successivo declino chiusino: la costruzione del cosiddetto “Muro grosso”, da parte degli orvietani (su ordine del papa tedesco Leone IX). Una diga di mastodontiche dimensioni (120 metri di larghezza, 21 di altezza e 8 di “spessore”) sul Clanis all’altezza di Olevole, nei pressi di Fabro, che impedendo il deflusso del fiume verso il Tevere allagò tutto il fondovalle isolando Chiusi e facendo diventare la vallata su cui il Clanis scorreva, una palude fetida e malsana, fonte di malaria, di morte e di miseria…
Tanto che Dante nella Commedia, Canto XVI del Paradiso, tre secoli dopo, cita Chiusi come esempio di nobiltà decaduta: “se tu riguardi Luni e Orbisaglia come sono ite, e come se ne vanno /di retro ad esse Chiusi e Sinigaglia, /udir come le schiatte si disfanno /non ti parrà nova cosa né forte, /poscia che le cittadi termine hanno”.
Nel 1300 di ciò che Chiusi era stata in passato rimaneva ormai ben poco. Oggi meno ancora. Ma il declino non cancella la storia. E forse, anzi, certamente, la storia della Chiusi Longobarda e Carolingia è rimasta finora materia per studiosi e appassionati, non è diventata mai senso comune. Eppure in quei secoli la città ebbe un’importanza superiore a quella che ebbe con la lucumonia di Porsenna. Il Museo Nazionale Archeologico racconta molto di questa parte di storia, ma per i più è un museo etrusco. La collina dell’Arcisa ha restituito reperti importanti di epoca longobarda durante gli scavi fatti nell’800 e nei primi decenni del ‘900, ci sono state successivamente varie pubblicazioni e una mostra, una decina di anni fa…
Ma è poco, troppo poco, rispetto al ruolo e al peso militare, politico e religioso che Chiusi ebbe dopo le famigerate invasioni barbariche, fatte però da popoli, regnanti e condottieri che tanto barbari non erano.
P.S. Domenica scorsa a Cividale del Friuli si è giocata la partita di basket di A2 Cividale-San Giobbe Chiusi. In pratica un derby in salsa longobarda… La partita di domani mercoledì 21 dicembre, San Giobbe Chiusi-Nardò, idem… La Longobarda Chiusi contro i longobardi del nord est e contro i longobardi del sud. Anche lo sport può aiutare a saperne di più sulla propria storia.
m.l.
Nella foto: statue longobarde a Cividale del Friuli (Arengario.net)






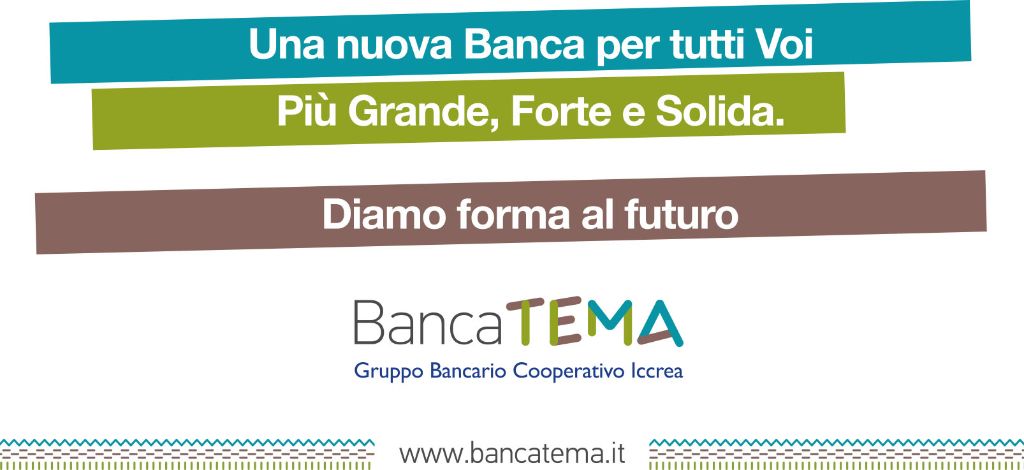




Sul periodo “barbarico” di Chiusie esiste un bel volume intitolato “Goti e Longobardi a Chiusi” della collana “I Tesori di Chiusi” edito da Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco-Umbro e uscito nel 2013. Il volume, curato dalla professoressa Carla Falluomini è il terzo di una collana che ha visto la pubblicazione nel 1997 di “Chiusi Cristiana” e nel 2000 di “Chiusi Etrusca”.
Credo che pochi sappiano che intorno al 1300 Chiusi battesse anche moneta, od almeno così si racconta….. Mi sembra che qualche anno fa ci fu una notizia sottolineata da Fulvio Barni di Chiusi che è un esperto numismatico e storico chiusino in base alla quale si pensa che fossero esistiti due reperti conoscuti come ”Grosso di Chiusi” della serie tipica dei ”Grossi Agontani” dei quali uno fu sottratto non si sà in quali circostanze e l’altro pezzo superstite si suppone sia custodito nelle casseforti della Zecca di Stato a Roma. Qualcuno dice che uno di questi pezzi si trovi al British Museum di Londra non si sà se esposto oppure cutodito in qualche altra parte di tale museo. Insomma è una storia questa che aggiungerebbe un tassello di mistero specificatamente al fatto della zecca supposta chiusina ma certezza invece sul fatto dell’importanza intorno ad un periodo che anche se profondamente decadente di Chiusi non farebbe altro che sottolinearne l’importanza e che la ex locumonia etrusca ,poi romana, poi longobarda sia stata al centro di traffici riconosciuti se non altro come crocevia logistco e di conseguenza anche economico. In quel periodo credo che esistessero anche molte zecche che coniavano monete in maniera libera non sottoposte ed alcun vincolo imperiale o comunque che definisse l’appartenenza di un territorio ad una signoria e già questa storia è misteriosa solo per tale fatto. Nemmeno Don Bersotti a pag.133 della sua celebre ” Storia di Chiusi” pur pubblicando una immagine di come era-o sarebbe identificato- il famoso ”Grosso di Chiusi” non nè fornisce alcuna certezza che sia stato coniato a Chiusi o almeno non ho rintracciato dove lui stesso ne parli.Sono storie queste che sconfinano in un mistero e nelle nebbie del tempo, che varrebbe la pena andassero svelate od almeno cercate di ricostruire ,anche per fare le differenze fra ciò che è stata Chiusi ieri e cio’ che è Chiusi oggi.
Per vedere e comprendere la differenza tra ciò che Chiusi è stata e cosa è oggi non serve andare a cercare le monete coniate o non coniate dalla città. Bastano i documenti storici e i reperti già conosciuti. Questo articolo, che non è un saggio, ma una semplice constatazione/riflessione giornalistico divulgativa, sulla Chiusi longobarda e carolingia, tra il 450 d.C. e l’anno 1000, evidenzia come per alcuni secoli Chiusi sua stata una vera e propria potenza, non solo uno snodo logistico. Ma evidenzia anche il fatto incontrovertibile che questa parte di storia della città non sia stata e non sia adeguatamente conosciuta e valorizzata, pur essendo facilmente rintracciabile.