GLI STATI GENERALI DELLA CULTURA E LO STATO DELLA CULTURA

Marco Lorenzoni ha spesso proposto di indire gli Stati Generali della Cultura, espressione sicuramente di grande effetto, oltre che di Moda, ma che va specificata, perché dietro questa insegna si possono intendere diverse modalità. Di sicuro dovrebbe avere almeno come obbiettivo quello di “coinvolgere attivamente gli operatori, le istituzioni culturali e gli amministratori pubblici…invitandoli ad essere parte attiva nella scrittura di linee guida condivise e di prospettiva”. Così recita la premessa degli Stati Generali promossi dalla Regione Piemonte.
Oppure, come nel caso del Sole24, si tratta di approfondimenti specifici affidati a relatori “pesanti” come a Firenze lo scorso anno: il Ministro Franceschini, Melandri, Della Valle e così via, con in testa il Sindaco Nardella. Ci sono poi altre declinazioni che prevedono un segmento temporale dedicato ai relatori (ma chi li sceglie?) e a tavoli tematici di approfondimento con gli operatori del settore (ma chi li sceglie?). In questo caso se sono tanti, spesso sono troppi, trasformandosi in Vetrina ed escludendo ogni forma di dialogo e di confronto (se non altro per ovvi motivi di tempo)
Ultimo, ma non meno importante: chi tira le fila di tutti questi contributi e, soprattutto, chi li trasforma in prassi, per usare un termine antico? In sostanza, sono solo chiacchiere o qualcuno poi si impegna a farle diventare indicazioni per un nuovo corso?
Se l’iniziativa è promossa da un Ente locale, vi è almeno qualche possibilità che si possa trattare di una consultazione reale, che dia le linee guida di una futura azione; se è invece promossa da privati, essa deve comunque riuscire ad aggregare soggetti in grado poi di farsi sentire, se non si vuole rischiare che la bolla di sapone esploda poco dopo la sua creazione.
Diciamo quindi che l’esigenza di un confronto plenario con le forze in campo è reale e legittima ma che le modalità di esecuzione, oltre alla naturale entropia, si dimostrano sempre discutibili.
L’ultima volta che vi partecipai – mi ritrovai inserito in un tavolo tematico non corretto rispetto alle mie competenze – eravamo una ventina (tanti, troppi) ma mancavano soggetti che operano sotto il radar istituzionale mentre ne erano presenti altri ormai usurati. Inutile dirci che, di quel lavoro, non se ne è mai saputo nulla, nemmeno la soddisfazione formale di ricevere la preannunciata sintesi tematica e operativa. Insomma, come spesso accade, si trattava di una vetrina per attivare il falso movimento delle consultazioni “dal basso”… la famosa Partecipazione che non manca mai nei programma elettorali e che però poi, in qualche modo, va simulata per non disattenderne le attese.
Vi è oggi una domanda che credo sia più produttiva dei risultati di generici Stati Generali della Cultura e che riguarda invece lo “Stato della Cultura” ovvero la definizione e la possibile condivisione di cosa significhi Cultura nel 2000. Senza poter chiarire e condividere questo termine e cosa esso rappresenti, si rischia di usare una parola che ha oggi mille significati diversi, con il rischio più che concreto, di parlarsi a vuoto intendendo cose diverse; e questo anche in assenza di malafede da parte di alcuni dei soggetti in campo.
Cultura in generale e Cultura nel particolare di un territorio, in questo caso di un territorio di confine e di passaggio, di Terme, di retaggio Etrusco ma anche di melting pot; di tradizioni popolari ma anche di necessità che la forza centrifuga non le disperda e le integri con la modernità. Di Cultura come memoria, come coltivazione del bello ma anche come occasione che essa venga proposta ad un grande popolo di viandanti globali ovvero il Turismo culturale che porta reddito e, allo stesso tempo, la ricchezza umana del confronto con altre realtà. Non credo, se attuata correttamente, che vi sia incompatibilità tra Cultura e Turismo culturale, essendo esse facce della stessa medaglia.
Per concludere e sintetizzare: prima degli Stati della Cultura credo sarebbe meglio, e più opportuno, definire lo Stato della Cultura, inclusa quella delle Performing Arts che invece, per molte ragioni, continuano ad essere le protagoniste principali.
Paolo Miccichè







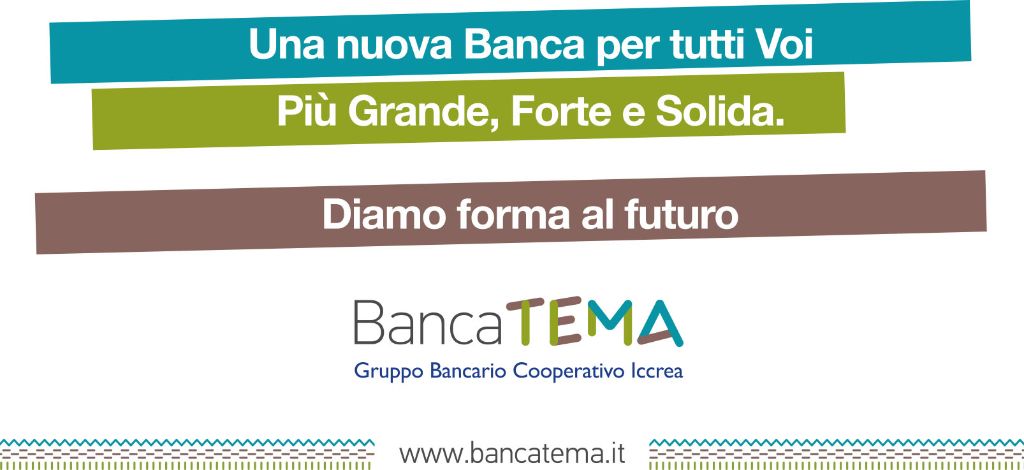




Sì, Paolo, la proposta degli Stati generali la feci su primapagina – ancora cartaceo – nel 2012. E riguardava la realtà specifica di Chiusi che era in un momento di cambiamenti: stava finendo l’era Rutelli nella gestione del festival estivo e della stagione invernale, si stava costruendo la Fondazione, era in atto una fuga di musicisti e teatranti verso altri paesi della zona, sul settore archeologico gravava un silenzio di tomba (e non è una battuta). MI sembrava insomma un passaggio necessario. Per fare l’inventario delle risorse materiali e umane, delle strutture disponibili, per fare il punto sullo stato dell’arte e indicare, se necessario, strade nuove per mettere a frutto le risorse e le strutture di cui sopra… Chiaro che la proposta prevedesse la partecipazione, se non l’organizzazione dell’evento, da parte dell’Ente Locale e delle istituzioni preposte (Fondazione, Soprintendenza ecc..). Perché in assenza degli interlocutori deputati il ragionamento sarebbe uscito fuori mozzo, incompleto, parziale e la cosa sarebbe stata vissuta probabilmente come una rivolta dei peones, degli scontenti, dei soliti rompicoglioni e le proposte eventuali avrebbero avuto poche chances di trovare accoglienza… Da allora alcune cose sono cambiate ci son stati avvicendamenti nelle istituzioni, il festival estivo ha preso una direzione diversa, così come la direzione del Museo… Ma a mio avviso la proposta resta attuale,anzi forse ancora più necessaria. L’intervista recentissima del direttore artistico del festival Orizzonti, per esempio, ha aperto un nuovo fronte, delinea scenari diversi da quelli dichiarati in apertura di mandato dalla presidente della Fondazione, c’è di mezzo il rapporto di quell’evento con le realtà teatrali del territorio ecc… Insomma mi pare che un chiarimento sia quantomeno necessario e anche urgente. Il dibattito seguito all’articolo di primapagina su quell’intervista lo dimostra, pur avendo a tratti debordato su altri aspetti… Per questo motivo ho continuato a insistere in tutti questi 4 anni, e anche nelle ultime settimane. Qualcuno ha proposto di allargare il ragionamento al comprensorio, uscendo dall’ambito strettamente chiusino. Si può fare, sarebbe forse anche più interessante (ma un po’ più complicato). E si può anche evitare di chiamarli Stati Generai se il termine può apparire pretenzioso, o antico o troppo giacobino… Ma un confronto sullo stato della cultura e su come farla diventare punto di forza e non solo fiore all’occhiello di una città o di un territorio, e farlo con tutti gli addetti ai lavori e con coloro che poi sono chiamati a decidere, organizzare, e pagare gli eventi, mi sembra, oggi come 4 anni fa, e ancora di più, un passo necessario, irrinunciabile e non rinviabile. Il nome e le modalità sono, alla fine, fatto secondario.
Ma si Marco, certo che l’esigenza c’è ed è sacrosanta e, ovviamente, non è un problema di nome ma di sostanza. (un tempo non si chiamavano Stati Generali della Cultura ma sparavano ugualmente “a salve”).
Se però non si definisce cosa è Cultura e – ancor più – cosa il Pubblico deve fare (e cosa non deve fare, essendo soldi della Comunità) per la Cultura, si va poco lontano.
Allora mi chiedo: invece di infrangersi sugli scogli del “vorrei ma non posso”, promuoviamo una riflessione sulla Premessa ovvero sul bisogno di Cultura; una riflessione di intellettuali, di addetti ai lavori e anche, se possibile, di cittadini che magari aiutati da una specie di questionario diano un’indicazione di percorso. Cultura Viva, Viva la Cultura mi verrebbe da dire….